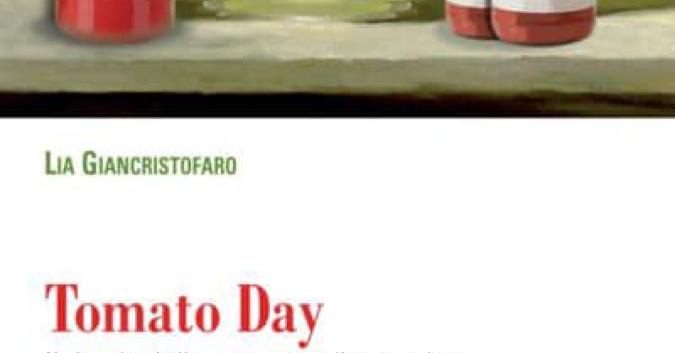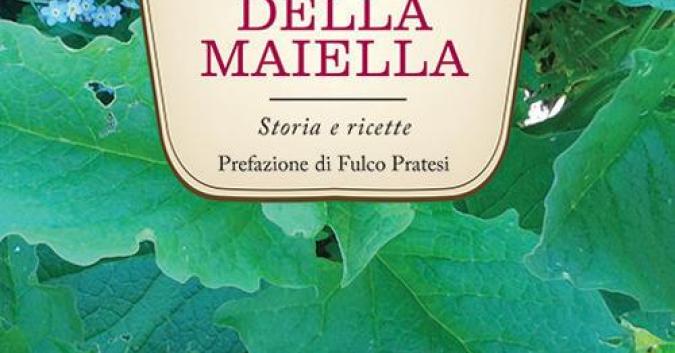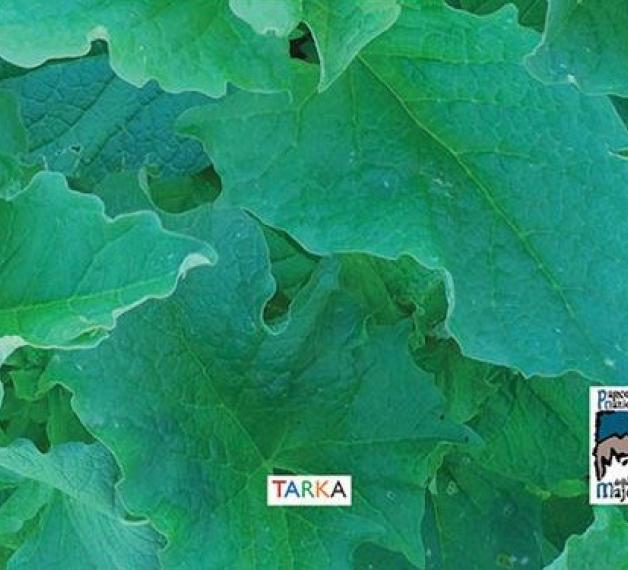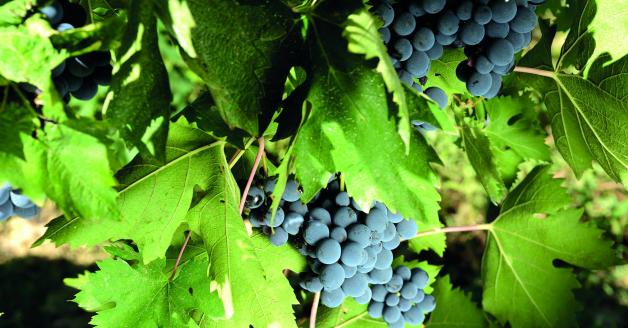Nel suo orto, Primavera coltiva anche le varietà pregiate pomodoro “a pera” abruzzese e il “mezzo tempo” vastese, indispensabile quest’ultimo per preparare il brodetto di pesce, varietà queste presenti su tutto il territorio, dalla costa alle zone pedemontane. Nel suo libro ‘La cucina della Maiella’ scrive: “nella nostra cucina i pomodori trovano il loro uso più classico nelle “buttije” (bottiglie), che ancora molte famiglie preparano durante i mesi estivi con un rituale che poco o nulla è cambiato nel tempo… “Passate” o “a pizzitte” (a pezzi), cotta o cruda, con i peperoni (“pipidigne e pummadore”), ancora oggi la “buttije di pummadòre” resiste alle malìe delle passate da supermercato”.
Le “bottiglie” sono un vero e proprio cult della cultura rurale abruzzese, arrivando persino a diventare un “totem”, definizione della docente di Antropologia Culturale dell’Università D’Annunzio, Lia Giancristofaro.
“Le bottiglie di pomodoro fatte in casa – scrive Rodrigo Cieri - assumono il significato del “bene intangibile” e rientrano in un rituale legato al giorno della bottiglia, giorno sacro, in cui le famiglie si ricompongono legate dalla forte emozione. La salsa fatta in casa ha il suo ciclo completo in loco e tuttavia, quasi in forma sotterranea, dai garage e cantine delle nostre abitazioni, viene esportata nelle città del centro e del nord Italia.
La “bottiglia” anche impolverata della cantina è un’altra cosa (rispetto alla confezione che si trova in commercio). È un sapere e un sapore di casa. Si evolvono le tecniche, ma quell’emozione legata al valore patrimoniale è unica, intangibile.
Personalmente faccio parte di quelli che da ragazzo, chiamato da vari parenti e famiglie amiche, legava i tappi di sughero con lo spago. Senza guanti lascio immaginare i segni lasciati sulle mani. Anch’io, prima dell’acquisto dell’ultima macchinetta elettrica, ho legato la vecchia, di cui ero addetto a girare la manovella, al motore della lavatrice. E che velocità! Bisognava sbrigarsi e con il mestolo ben capiente a versare il pomodoro bollente perché venisse ‘passato’.
E poi l’emozione finale! Che sudata per far bollire le cento bottiglie a bagnomaria dentro il caldaio di rame con la fiamma delle ceppe!”
“Si tratta di una eredità contadina - spiega la professoressa Giancristofaro - che stiamo traghettando nel futuro… mantiene una grande carica di voglia di fare, di entusiasmo e soprattutto di unità familiare. Eredità contadina contenuta nella pratica di mettere da parte un prodotto quando è in esubero per consumarlo nei periodi di carenza”.
Il giorno della passata inizia presto, anche alle 4-5 del mattino. Secondo la studiosa “la tradizione della preparazione casalinga della passata è una forma sommersa di folclore della quotidianità dell’estate, un ricordo di quando eravamo poveri prima del boom economico… il pasto per chi è lontano dalla terra d’origine diventa anche il pasto per la mente”.
Del pomodoro in cucina Giancristofaro ha parlato nel libro Tomato Day: la salsa di pomodoro viene citata per la prima volta nel 1692, ma bisogna aspettare il 1839 per vederla abbinata alla pasta come condimento. La produzione casalinga della passata è cambiata molto negli ultimi ’70 -‘80 anni. In Abruzzo e Molise si è iniziato a fare uso delle bottiglie solo dopo il passaggio del fronte di guerra. Allora le truppe alleate erano vettovagliate con prodotti a lunga conservazione imbottigliati. Dopo il loro passaggio i ragazzi venivano mandati a esplorare i resti degli accampamenti e recuperavano le bottiglie vuote che venivano riutilizzate per usi casalinghi, che prevedevano la bollitura, quindi principalmente la passata. E dalla rivoluzione delle bottiglie si è rapidamente passati a quella dei tappi. L’utilizzo di quelli a corona è storia recente. I primi tappi erano i torsoli delle pannocchie di granturco intagliati e legati alla bottiglia con dello spago. In seguito arrivarono i tappi di sughero. Per la preparazione della passata si usava il setaccio, poi è arrivata la macchinetta a manovella che è stata portata anche oltreoceano dai nostri emigranti. Negli anni Ottanta è arrivato il passapomodoro elettrico, già inventato prima attaccando al passapomodoro a manovella il motore a due tempi della lavatrice. Ora le macchine passapomodoro elettriche sono sempre più sofisticate, ma l’evoluzione tecnologica non riesce a scalfire la sacralità antica del rito per la preparazione del liquido rosso che è un vero e proprio totem della famiglia italiana. La passata di pomodoro nell’inverno continuerà a parlare di casa, famiglia e radici.
Lo spuntino tipico del giorno della passata era ‘pane e pomodoro’, reso più gustoso da un filo d’olio e un pizzico di sale. Oggi viene servito quasi esclusivamente in particolari occasioni legate al ricordo dei sapori antichi, sostituito dal goloso pane e cioccolata.
Lo chef Giuseppe Tinari di Villa Maiella di Guardiagrele ha reinterpretato il pomodoro facendolo diventare un dolce: "pomodoro candito, latte alla vaniglia e olio al basilico".
"Una grave perdita – secondo Gino Primavera - è invece stata l’abbandono della tradizione della ‘cunzèrve’, concentrato di pomodori e peperoni rossi che si faceva essiccare lentamente al sole entro recipienti di legno, le “canalette”, fino ad assumere una consistenza densa e un gusto pronunciato. Un cucchiaio di cunzèrve tingeva di rosso anche il più esangue e povero dei sughi e col suo sapore grasso e acidulo costituiva uno dei trucchi della cucina povera che servivano per rendere i cibi più forti di sapore".
Nel suo libro più recente “Tutto Fiorisce a Primavera”, l’esperto fa un vero e proprio elogio del pomodoro:
Lode ai pomodori
A marzo i pomodori arzilli già zampettano, zip-zap
impazienti dentro i semini salvati in autunno.
Per magia cinetica fremono e si riproducono uguali
a sé stessi, vibrano danzando nell’eterno rinnovo
e io ballo con loro.
Nell’anima tremula del semino
si nasconde il semino del tempo che muta,
diventa verde e poi rosso per destino segnato.
Si racconta che i colori che cambiano
sono come il segreto di Pulcinella.
E poi nascono le piantine, le metto a dimora
inzaccherate di terra bagnata, le circondo
di letami pregiati; si ergono assurgenti verso
l’azzurro del cielo, con i primi fiorellini gialli
che ambiscono a diventare rosse bacche.
Si arrogano la libertà di una crescita veloce,
si inerpicano indeterminati su lunghi sostegni,
piegano le foglie ai dardi del sole cocente
per proteggere e dare riparo ai preziosi frutti
come nell’incavo di una fresca tana nei boschi.
…